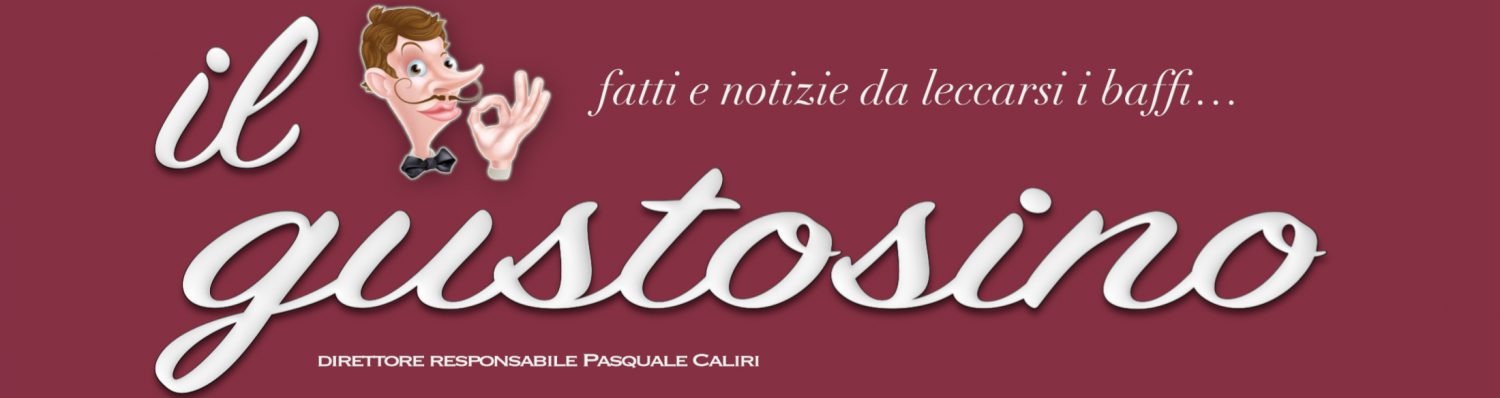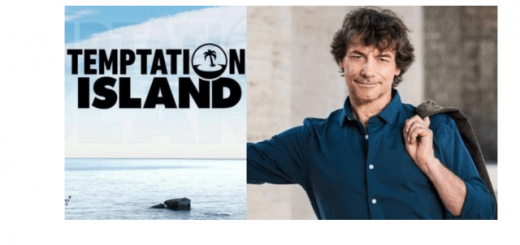Solitudine digitale: la soluzione per l’anima è disconnettersi e fuggire dai social.

La “ludopatia da like” è un manifestazione tipica della gamificazione della vita: ogni emozione diventa un contenuto spendibile, ogni interazione un punteggio, ogni relazione una competizione. L’alternativa è ritrovare dentro di noi quello spazio dove incontri l’altro negli sguardi e non sugli schermi.
Viviamo in un’era in cui la connessione permanente è considerata normale, desiderabile, persino necessaria. Ogni gesto, emozione, traguardo o fallimento può (e spesso deve) essere condiviso, commentato, apprezzato. Siamo immersi in una narrazione digitale continua, che plasma le nostre relazioni, ridefinisce i nostri confini e riduce la nostra interiorità a emoji e reazioni. Ma c’è chi si oppone. C’è un’anima resistente che dice “no”. È l’anima no-social, quella che sceglie il silenzio al posto dell’ostentazione, la presenza reale al posto della visibilità virtuale.
Su questo tema si concentra l’articolo “L’anima no-social contro la ludopatia da like”, scritto da Lucio Iaccarino e pubblicato su HuffingtonPost.it, una riflessione acuta e profonda sul modo in cui i social network stanno modificando — in alcuni casi deformando — il nostro modo di stare al mondo.
Nel suo articolo, Iaccarino propone un parallelo tanto audace quanto lucido: “la dinamica dei social network assomiglia sempre più a una forma sottile di dipendenza, che potremmo definire, senza troppi indugi, ludopatia da like”. Una definizione che sposta il focus dalla tecnologia in sé all’uso compulsivo che se ne fa, legato non a un bisogno comunicativo autentico, ma alla ricerca spasmodica di conferme emotive.
Come nelle slot machine, anche nei social “i gettoni cadono a grappoli” sotto forma di emoji — cuori, risate, lacrime, fiamme, applausi — riducendo le emozioni a simboli grafici privi di profondità. Un gesto, quello di cliccare “mi piace”, che può sembrare banale ma che diventa strumento per misurare il valore personale, il grado di affetto ricevuto, persino la tenuta di una relazione.
Iaccarino racconta come la vita reale venga traslata in una continua messa in scena virtuale, dove eventi privati diventano “contenuti social” — compleanni, diplomi, lauree, traslochi, battesimi, tutto può essere postato, filtrato, condiviso. E chi non partecipa a questo rito collettivo della visibilità rischia di essere percepito come assente, sospetto, addirittura deviato.
Un italiano su quattro, però, secondo quanto riportato, sceglie consapevolmente di tenersi lontano dai social. Non si tratta di tecnofobia, ma di un rifiuto critico nei confronti della dipendenza da connessioni virtuali. Questi “no-social” non vogliono essere spettatori né attori di un mondo regolato da “algoritmi opachi”, dove le dinamiche relazionali vengono decise da calcoli automatizzati e dove “l’assenza di un like può causare incidenti relazionali che dal virtuale risalgono drammaticamente al mondo reale”.
Da un punto di vista sociologico, il fenomeno descritto da Iaccarino è esemplare del passaggio dalla società dell’interazione faccia a faccia, e a sottolinearlo è stato anche il sociologo Erving Goffman, a una società performativa e digitale in cui l’identità è costruita, confermata e validata pubblicamente.
Le piattaforme digitali, nella loro logica algoritmica, producono una forma di controllo sociale soft, dove ogni individuo è motivato a produrre contenuti per ottenere riconoscimento. Si tratta, come sosteneva Michel Foucault, di un nuovo dispositivo di potere, che non reprime ma seduce, che non impone ma orienta i comportamenti.
La “ludopatia da like” è una manifestazione tipica della gamificazione della vita sociale, un concetto chiave nelle analisi recenti della digitalizzazione: ogni interazione diventa punteggio, ogni relazione una competizione, ogni emozione un contenuto spendibile.
Ma la deriva più preoccupante è quella della costruzione distorta della realtà. I social non riflettono il mondo, lo ricreano attraverso narrazioni selettive, estetizzate, incentrate sull’apparenza e sul consenso. Si crea così un ambiente in cui l’individuo, per esistere, deve mostrarsi continuamente. La disconnessione, dunque, diventa atto di resistenza simbolica, un rifiuto del “panopticon digitale” e un’affermazione del diritto alla complessità, al tempo lento, alla relazione non mediata.
In un tempo che ci chiede di essere sempre visibili, sempre connessi, sempre pronti a piacere, la vera rivoluzione è diventare invisibili per tornare autentici. Spegnere lo schermo, anche solo per un attimo, non è fuga ma scelta. È un modo per ritrovare lo sguardo diretto, la voce non filtrata, il valore della presenza reale.
I no-social ci ricordano che esiste ancora un luogo sacro dentro di noi che resiste all’algoritmo, che cerca silenzio invece di notifiche, profondità invece di visualizzazioni. Sono i testimoni di una possibilità alternativa, forse minoritaria, ma potentemente umana: quella di vivere senza dover apparire, di amare senza dover postare, di essere senza dover “piacere”.
Non è isolamento. È una forma nuova di “socialità antica”, dove l’altro si incontra nello sguardo e non nello schermo, dove la felicità non si misura in reaction ma in impressioni autentiche. E forse, proprio da questa scelta controcorrente, potrebbe nascere un nuovo modo di abitare il mondo. Più vero. Più umano.