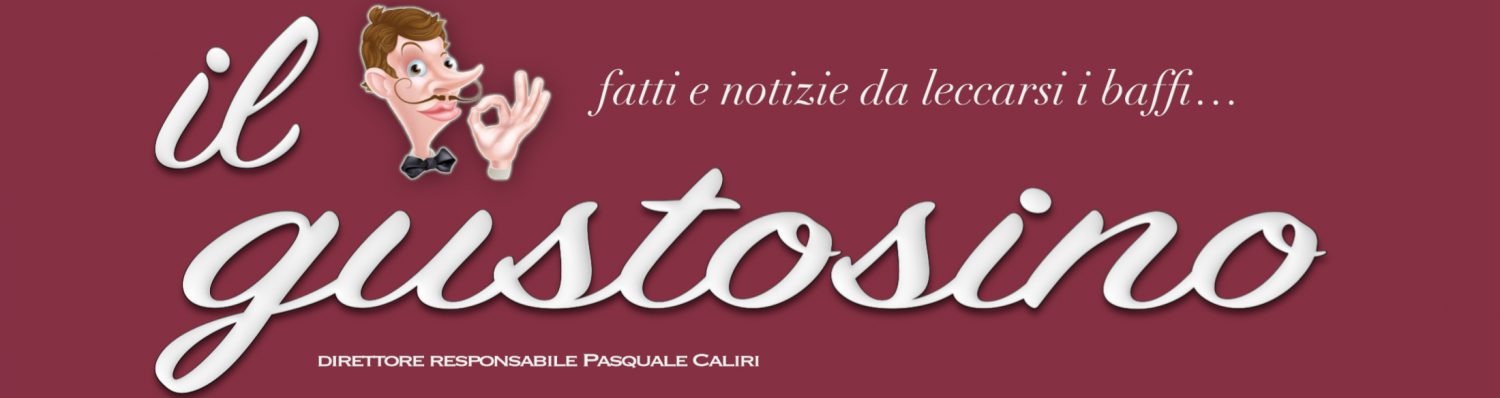Il termine “Busiate” della nota pasta siciliana inserito nello Zingarelli.

La recente edizione del vocabolario riconosce la denominazione della preparazione prodotta tradizionalmente rotolando l’impasto attorno ad un ramoscello di erba “Busa.
Nell’edizione 2026 dello Zingarelli sono state inserite le busiate, la tipica pasta trapanese, dando un riconoscimento al suo valore culturale e gastronomico, identificandola come un simbolo della cucina siciliana, la cui origine è legata all’uso di strumenti, i “busi” o “buso”, per attorcigliare l’impasto e dare forma alla pasta.
È un riconoscimento per la gastronomia siciliana che, tra le sue prelibatezze, conta ora anche la pasta tirata a mano una volta con la ‘disa’, la pianta Ampelodesmos mauritanicus, tradizionalmente utilizzata in Sicilia, in particolare nella provincia di Trapani, per dare la forma elicoidale alle busiate. Il nome “busiata” deriva infatti dal termine siciliano “busa”, che indica il gambo di questa erba locale. Per produrre la pasta, un filo di impasto di semola di grano duro viene arrotolato attorno a un ramoscello della pianta.
La fama della busiata è strettamente legata al pesto alla trapanese, con pomodoro, mandorle, aglio e basilico: la forma a spirale trattiene il sugo in modo perfetto, rendendo questo piatto tra i più rappresentativi della cucina siciliana. Dalla ‘disa’ si è passati alla ‘busa’ (da cui trae origine il nome della pasta), i sottili ferri di metallo utilizzati per fare la maglia, lasciando ora spazio alla preparazione con i mezzi meccanici. Una pasta povera che, insieme al pesto alla trapanese, racconta la storia di un territorio e che celebra anche una sagra giunta alla XXI edizione che si organizza ad agosto a Salemi un comune di provincia di Trapani, nella Valle del Belice, che sorge sul sito dell’antica città elima di Halyciae ma anche a Buseto Palizzolo nel trapanese, dove da tredici anni la si degusta anche col sugo di carne.
L’ingresso della busiata nello Zingarelli si inserisce in un contesto più ampio, quello di una lingua in continua evoluzione, che riflette cambiamenti culturali, sociali e tecnologici. Tra i nuovi termini figurano espressioni di uso comune e neologismi che raccontano fenomeni contemporanei.
Il nome “busiata” ha ormai varcato i confini italiani: lo scorso febbraio è arrivata addirittura sulla tavola della Famiglia Reale britannica e negli anni ha conquistato anche i palati di presidenti della Repubblica come Scalfaro, Ciampi e Napolitano, nonché di campioni di Formula Uno.
Zanichelli la definisce così: “Busiata [dal sicil. busa, bastoncino intorno a cui si confeziona la pasta;] s. f. (spec. al pl.), tipo di pasta di forma elicoidale a base di semola di grano duro, tipica della Sicilia occidentale”. Dal passato contadino alle cucine stellate, la busiata si conferma non solo una pietanza, ma un simbolo di identità culturale e riscatto gastronomico. Con l’ingresso nel vocabolario italiano, diventa ufficialmente patrimonio linguistico e culinario. E, come spesso accade in Sicilia, tutto parte dalla tavola.
Il ferro da calza rende busiata la pasta fresca lunga tipicamente servita con il pesto alla trapanese (basilico, aglio rosso, mandorle, pepe nero , pomodorini perini, pecorino) e più modernamente con il pesto alla siciliana che contamina la ricetta originaria con altri ingredienti (ricotta, pinoli, parmigiano, pomodori ramati)
Di denominazione similare sono gli “Gnocculi”, gnocchi di farina di grano duro la cui preparazione è diffusa in tutta l’isola, con una variante tipica della Sicilia occidentale (Erice) rappresentata dalla cavatura con il ferro da calza (busa), da cui la denominazione Gnocculi busiati ” che sono serviti con salsa di pomodoro e melanzane, o con ragù di carne.