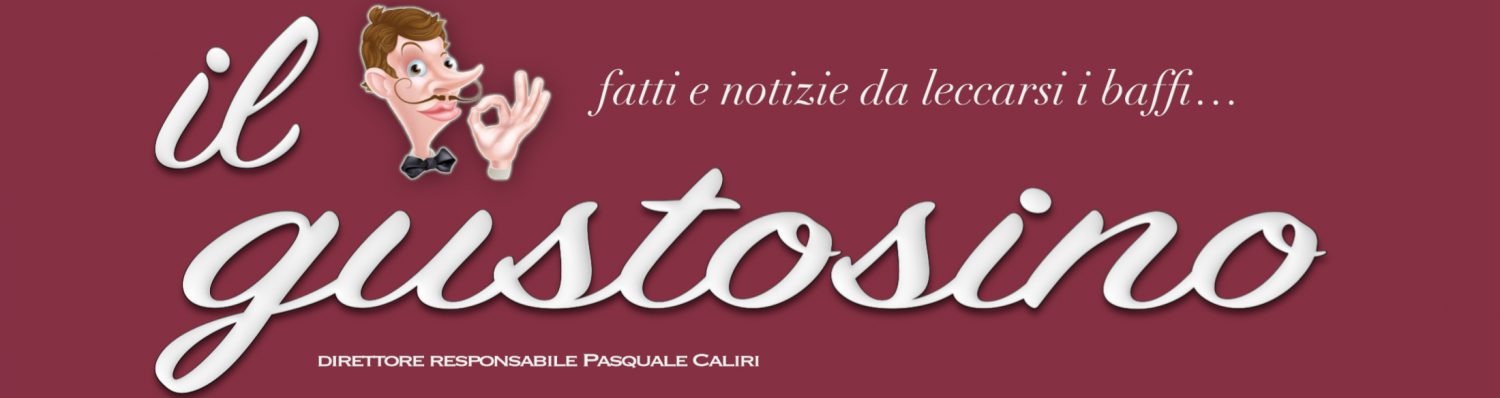Come la demenza sui social è diventata un business: benvenuti nella Brainrot Economy.

Contenuti privi di senso trovano spazio perchè aumentano le visualizzazioni, una estetica digitale sintomo di trasformazioni economiche ma anche cognitive ed identitarie.
È davvero ricco di spunti di riflessione l’articolo firmato dalla giornalista Elisabetta Rosso, pubblicato su Fanpage.it e intitolato “Benvenuti nell’era della Brainrot Economy: come i contenuti demenziali sono diventati un business”.
L’analisi che propone va ben oltre la semplice osservazione di una moda virale: esplora un fenomeno che, se letto in chiave sociologica, svela molto della contemporaneità. Ci parla di una nuova economia dell’assurdo, di un’estetica digitale che ha messo radici profonde nella cultura dei social media e di come questa sia sintomo – ma anche causa – di trasformazioni cognitive, identitarie ed economiche.
Il fenomeno dei “Brainrot” è una delle manifestazioni più recenti e significative di come il contenuto online si sia trasformato in una merce, in una forma di capitale simbolico ma anche materiale. Come spiega la giornalista, “i Brainrot – ibridi nonsense generati dall’intelligenza artificiale che hanno invaso i social – non sono solo un’estetica, ma un nuovo business”. Un’osservazione, che pone al centro dell’attenzione la metamorfosi del digitale da luogo di espressione a vera e propria fabbrica dell’attenzione, dove l’irrazionale e il grottesco diventano strumenti di monetizzazione.
Il termine “brain rot”, dichiarato parola dell’anno 2024 dalla Oxford University Press, viene tradotto come “marciume cerebrale”. È un’espressione forte, che “indica l’effetto logorante provocato dalla fruizione continua di contenuti digitali ripetitivi, demenziali o poco stimolanti”. Ma è anche, come sottolinea l’articolo, una descrizione efficace dei contenuti stessi: paradossalmente, ciò che ci aliena è ciò a cui partecipiamo con più fervore.
Un aspetto particolarmente rilevante è la nascita di un’economia parallela, definita “Brainrot Economy”. “Diversi creator vendono prompt, video lezioni, guide PDF e accessi a community riservate che promettono la formula magica per ‘esplodere’ sui social”. È il trionfo della vetrinizzazione dell’identità, un concetto chiave della sociologia contemporanea. In un’era sempre più orientata alla performance e alla visibilità, anche la creazione di contenuti privi di senso trova spazio purché porti engagement, visibilità e, soprattutto, profitto.
Elisabetta Rosso evidenzia che “molti creator non si limitano a pubblicare, ma monetizzano i contenuti”. È il passaggio cruciale: l’arte dell’assurdo si trasforma in mercato, la creatività in impresa. “Online ci sono PDF-guida da 35 euro su come costruire il proprio universo ‘Brainrot’ e sfondare su TikTok”. In altri casi, “creator come Fusion Boy propongono lezioni video a 70 euro”. Non è un caso isolato. Alcuni raccontano di aver venduto “decine di corsi al giorno in pochi mesi”. La produzione di contenuti surreali non è più solo un gioco, ma un’attività imprenditoriale.
Tutto questo avviene in un contesto in cui l’individualismo digitale spinge ciascuno a cercare la propria “nicchia virale” per emergere.
In un tempo dominato dai social network, in cui ognuno è chiamato a “costruire il proprio brand personale”, anche un mash-up tra Putin, un gufo e una sirena può diventare una strategia vincente.
C’è poi l’aspetto della collaborazione tra creator e brand: “diverse aziende stanno cercando di sfruttare il potenziale di Tralalero Tralala o Cappuccina Ballerina”. Questo passaggio rappresenta la definitiva legittimazione economica del Brainrot.
Maggie Walsh, responsabile della strategia dell’agenzia di marketing digitale e social media Glow, ad Ad Age, ha dichiarato: “I meme non sono più solo un linguaggio di internet: sono diventati una vera e propria valuta culturale dominante”. Questo ci dice che ciò che fino a poco tempo fa era confinato ai margini del gusto e dell’estetica mainstream è ora al centro di una strategia comunicativa globale.
Il nonsense ha così assunto una nuova forma di legittimità. Non è più solo una fuga dalla realtà, ma un canale per costruire profitto. Un’estetica dell’eccesso, dell’assurdo e della deformazione che riflette, in controluce, le ansie e i desideri della società contemporanea.
C’è un messaggio profondo in tutto questo: nella crisi dell’attenzione collettiva, nel bisogno costante di stimoli sempre più estremi, vediamo l’effetto di un sistema che premia la quantità dei click a scapito della qualità del contenuto.
Ma in questo paesaggio surreale non mancano elementi positivi. Il successo di molti giovani creator dimostra come gli strumenti digitali, seppur usati in modi controversi, offrano opportunità di emancipazione economica e creativa. In un mercato del lavoro sempre più precario, l’inventiva – anche nella forma del paradosso – rappresenta per alcuni un’occasione concreta di riscatto.
La “Brainrot Economy” non va sottovalutata come una semplice follia del web, ma come un sintomo (e forse anche un effetto collaterale) di una più ampia trasformazione culturale. Un fenomeno che ci costringe a interrogarci sulla nostra relazione con l’informazione, con l’estetica e con il valore che attribuiamo ai contenuti. In un mondo dove tutto è vetrina, e ogni like è una micro-conferma identitaria, anche il surreale trova spazio. E questo spazio racconta molto di noi.